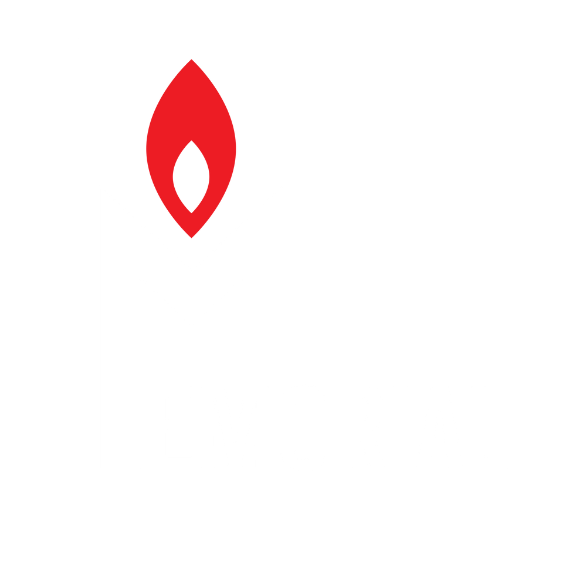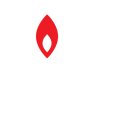Il Dubravlag di Jurij Dmitriev
Irina Galkova
18.04.2023
Irina Galkova, responsabile del Museo di Memorial, ha scritto un lungo resoconto sul caso di Jurij Dmitriev, sul suo processo e sul periodo che trascorre in colonia penale, ma anche sulla storia delle colonie penali della Mordovia, sul nuovo libro sul Dubravlag e l’importanza che la memoria assuma una sostanza materiale. Le colonie penali della Mordovia rappresentano uno dei complessi penali più grandi, la cui storia risale ai primi anni del Gulag. Nel 1931 proprio nel villaggio di Javas, dove Dmitriev sconta la pena di 15 anni a causa di accuse totalmente infondate di pedofilia, fu inaugurato il TemLag, il lager di Temnikov. Nel 1948, quando apparvero i “lager speciali per detenuti politici”, venne riorganizzato nel Lager Speciale n° 3 o Dubravlag. Con lo smantellamento del sistema del Gulag, i lager della Mordovia comunque non scomparvero. Il complesso di colonie penali, una parte delle quali era riservata ai condannati «per crimini contro lo Stato particolarmente pericolosi», continuò a essere chiamato in modo non ufficiale Dubravlag. Da queste colonie passarono molti dissidenti sovietici: Anatolij Marčenko, Julij Daniel’, Aleksandr Ginzburg, Tat’jana Velikanova, Irina Ratušinskaja, Jurij Galanskov, Kronid Ljubarskij e altri. Il testo originale è stato tradotto da Ester Castelli e Serena Ventura.
Jurij Dmitriev è il direttore della sezione di “Memorial” in Carelia. Per me Jurij è un mentore e collega che tempo fa mi è stato di grande aiuto per preparare la nostra spedizione sulle rive del Mar Bianco. Ci siamo conosciuti nel 2015, quando arrivai a Petrozavodsk per cercare nell’Archivio Nazionale della Carelia informazioni sui vari campi temporanei di lavoro distaccati da quelli delle isole Solovki. Allora mi spinse a riflettere da una prospettiva diversa, più profonda e seria, su ciò di cui ci occupiamo: dal suo approccio al tema si capiva che la storia delle repressioni non è soltanto un ambito di ricerca, ma un dolore smisurato, impresso nella memoria di diverse generazioni, mai portato alla luce, mai affrontato e mai pianto. Venire a contatto con questo dolore rende lo storico partecipe del dolore stesso e bisogna scegliere se farlo proprio oppure allontanarlo. Nel caso di Jurij le cose sono andate un po’ diversamente: nei primi tempi non era uno storico professionista e approdò alla ricerca proprio tramite l’elaborazione del dolore altrui e il desiderio di non respingerlo. Da più di trent’anni, metà della sua vita, Dmitriev studia le conseguenze dei crimini del regime di Stalin in Carelia: una parte del suo lavoro si svolge negli archivi, l’altra sul campo, alla ricerca dei luoghi di sepoltura segreti di quell’epoca. Dmitriev si occupa soprattutto delle fucilazioni avvenute all’epoca del Grande Terrore, tra il 1937 e il 1938, la cui verità non è mai stata svelata del tutto: molti luoghi delle esecuzioni non sono ancora stati trovati e i documenti d’archivio non sono mai stati desecretati. Ciò che sappiamo ora è merito di persone appassionate come lui. Il lavoro di riabilitazione della memoria delle vittime non è mai stato privo di ostacoli, ma negli ultimi anni è diventato semplicemente pericoloso. Nel 2016 Jurij Dmitriev è stato arrestato a seguito di una denuncia anonima, gli sono state mosse accuse false che hanno distrutto la vita della sua famiglia e per cui è stato condannato a lunghi anni di reclusione. Quasi in contemporanea con la sentenza finale sul suo caso, nel dicembre del 2021 sono state chiuse le due organizzazioni principali di Memorial a Mosca: in una di queste lavoravo io.
Nel novembre del 2022 io e Saša Kononova siamo andate a trovare Jurij in carcere. Saša è un’artista e regista, da studentessa ha partecipato ai viaggi studio della Scuola cinematografica di Mosca che l’hanno avvicinata alle ricerche sul campo di Dmitriev. Io e altri amici e sostenitori di Jurij siamo rimasti al suo fianco durante il processo: siamo andati alle udienze, abbiamo scritto articoli su di lui, sul suo lavoro e sull’enorme valore che ha. Il processo è durato cinque lunghi anni e per tutto questo tempo ci siamo visti e parlati solo di sfuggita. La nostra battaglia comune si è conclusa con una sconfitta, da cui è passato un anno intero. Dopo la chiusura di Memorial è iniziata la guerra che la Russia ha scatenato sul territorio dell’Ucraina: questa nuova mostruosità ha eclissato tutto ciò che accadeva in Russia. L’ha eclissato, ma non è riuscita a farcelo dimenticare. Anzi, ora più che mai ci sembra importante ripensare la storia che studiamo e in cui siamo immersi come un tutto indissolubile. Anche prima di incontrare Jurij Alekseevič, sapevamo che aveva iniziato a lavorare a un libro sul Dubravlag, uno dei campi di lavoro più noti dell’epoca sovietica, in cui ora è lui stesso rinchiuso.
Lo storico nella storia
Il fatto che, nei corsi e ricorsi della storia, un ricercatore dell’epoca delle repressioni finisca egli stesso tra le vittime è estremamente significativo, perché fa capire senza tante parole quanto il male possa ripetersi. Lo storico si trova allora davanti a una scelta terribile: disperarsi o trovare dentro di sé la forza per continuare a svolgere le proprie ricerche e da questo punto di vista esaminare gli avvenimenti, incluso il peso della sua nuova condizione. Dal centro di detenzione preventiva Jurij Dmitriev ha dato alle stampe i libri Krasnyj Bor [il boschetto di Krasnyj Bor fu luogo di esecuzioni tra il 1937 e il 1938, N.d.T.] e Ich pomnit Rodina (Li ricorda la Patria). Ha inoltre iniziato, con l’amico e storico Anatolij Razumov, la stesura di una raccolta in più volumi intitolata Mesto pamjati Sandormoch [Sandormoch, luogo di memoria; anche qui avvennero esecuzioni, N.d.T.] (per lavorarci hanno dovuto sfruttare i brevi incontri prima e dopo le udienze in tribunale, le rare visite e gli scambi per corrispondenza). Ha tenuto per i suoi compagni di cella un ciclo di lezioni sulla storia del posto. Dal palazzo-prigione di Petrozavodsk, dove è finito lui stesso in veste di imputato, negli anni ’30 passarono persone il cui viaggio terminò in una fossa comune, e le cui sorti Jurij ha dedicato trent’anni a riscattare dall’oblio. Per tanta vicinanza ai suoi eroi si è trovato a pagare un caro prezzo: mesi e anni sottratti alla sua vita.
Dopo cinque anni passati nel carcere di Petrozavodsk è iniziata una serie di trasferimenti, prima nel carcere situato nel piccolo centro di Nadvoicy (l’ex centro direttivo delle colonie penali del Mar Bianco e del Baltico, abbreviato in BelBaltLag, alla cui storia Dmitriev ha dedicato uno dei suoi libri), poi nelle carceri di San Pietroburgo, Nižnij Novgorod, Jaroslavl’, Rjazan’, in Mordovia… I campi di lavoro della Mordovia sono una delle prime grandi “isole” del sistema dei gulag, un intero distretto di colonie penali che non è sparito con l’abolizione della parte principale dell'”arcipelago”. “Quei campi sono noti, sono stati descritti molto bene in letteratura”, scriveva Dmitriev in una lettera alla famiglia poco prima di essere precipitosamente e inaspettatamente trasferito da Nadvoicy. La notorietà di quei luoghi, come si può intuire, non è affatto di tipo turistico, e la notizia del suo trasferimento proprio lì suonava allarmante. Nel maggio del 2022 abbiamo ricevuto le prime notizie di Jurij. Per la prima volta nei suoi anni di tribolazioni carcerarie Dmitriev è arrivato in un luogo che a lui, esperto della Carelia, non era capitato di studiare.
Prossima fermata Pot’ma
La colonia penale n.18 in cui ora è recluso Jurij Dmitriev si trova nel paese di Pot’ma. Così si chiama anche la stazione ferroviaria locale. Il treno da Mosca arriva alle quattro del mattino e a fine novembre a quell’ora è notte fonda. La banchina è coperta di neve, da entrambi i lati è buio pesto. “Pot’ma” nella lingua mokši, dell’etnia locale, significa “provincia remota, luogo sperduto”. E la prima impressione è proprio questa. La piccola stazione è l’unico edificio in cui si può aspettare l’alba al caldo. Oltre a noi c’è solo una donna di mezza età con un grande trolley. Non abbiamo bisogno di chiederle che cosa la porta qui… nella sala d’attesa improvvisamente scopriamo una sorta di museo: due piccole teche in vetro con ricami, vasellame, sandali del popolo mokši, di cui qui non sembra rimasto nessun rappresentante. Un cartello appeso al muro racconta la storia del paese e della stazione, tacendo vergognosamente sulle origini della “corsa all’edilizia del 1929-1930”. I campi non vengono mai nominati. Non ci sono dubbi: chi passa per questa stazione, come noi, quasi sempre sa perfettamente della loro esistenza. A chi è destinato questo resoconto storico opaco? Presto ci accorgiamo che la vera memoria di questo luogo è ancora presente, anche se in maniera meno evidente. Su una tecа è attaccato un pezzetto di cartone con un QR code. Seguendo il link si apre un blog con una descrizione dilettantistica delle principali testimonianze sulla rete dei campi e la loro storia, intitolata “La mia Mordovia. Dubravlag”. Il primo e principale luogo di interesse di tutti i paesi circostanti, la loro ragion d’essere, è la cosiddetta “zona”, nel gergo dei campi. La rete di colonie penali pervade tutto il distretto anche oggi – Javas, Zubova Poljana, Parca, Lesnoj, Moločnica –, in ogni paese ce ne sono una o due, a volte tre. A un certo punto da Pot’ma, che fungeva da snodo di transito, venne costruita una linea ferroviaria dedicata che collegava la maggior parte dei campi del distretto. Il treno andava da una colonia all’altra, ma ci viaggiavano anche i locali. La loro vita mai lontana da quei vagoni, dalle torri di guardia e dalle tradotte di prigionieri, era e rimane piuttosto singolare. Il “ramo” di Pot’ma non c’è più (la linea è stata chiusa e smantellata) ma è rimasta questa parola, che unisce i campi e i paesi in un’unica rete. Chi vive lungo il “ramo” in un modo o nell’altro ha a che fare con la “zona”, dato che qui non c’è proprio nessun altro lavoro. Rimuovere quel pezzetto di cartone dalla teca è semplicissimo. E forse i dipendenti della stazione lo toglieranno alla prima richiesta… Ad ogni modo siamo loro grati per questo tentativo di condividere la verità sulla storia locale.
Temlag. Dubravlag. Campo n. 58
I primi campi di lavoro nel distretto di Zubova Poljana apparvero nel 1931 con l’istituzione del campo di lavoro e rieducazione Temnikovskij all’interno del sistema dei gulag, appena fondato. Il suo centro direttivo si trovava nel paese di Javas, i vari distaccamenti sono cresciuti e si sono moltiplicati e verso il 1933-1934 il numero di prigionieri superava i 30 mila. I prigionieri tagliavano il legname e lavoravano alla sua prima trasformazione, oltre a costruire una nuova linea ferroviaria che collegava Rjazan’ a Pot’ma. Nel 1937 nel campo di Temnikovskij (abbreviato in Temlag) venne inaugurata una delle principali carceri femminili per migliaia di “mogli di traditori della patria”, i cui mariti vennero in gran parte uccisi negli anni del terrore staliniano. Nel 1948 il Temlag venne trasformato in campo a regime speciale per i criminali più pericolosi. La rete di questi campi, con nomi piacevoli quali “Rečnoj” (“del fiume”), “Ozernyj” (“del lago”), “Pesčanyj” (“della sabbia”), “Mineral’nyj” (“delle sorgenti minerali”) venne edificata alle fine degli anni ’40, nel contesto di una nuova ondata di repressioni. Il campo a regime speciale n.3, o Dubravnyj, divenne noto per la durezza delle condizioni di detenzione e per il fatto che, come ulteriore misura punitiva, si assegnava un numero a ogni prigioniero, invece del suo nome e cognome. Quasi tutti i prigionieri di questo campo erano “politici”, condannati per “attività antisovietiche”: questa espressione includeva qualsiasi giudizio negativo sulle autorità, espresso seriamente o per scherzo… Anche se il regime speciale ebbe vita breve (nel 1954 il Dubravlag venne trasformato in un campo ordinario) e con l’abolizione dei gulag dai documenti ufficiali sparì anche il nome “Dubravlag”, sostituito dall’espressione neutra Proprietà delle Ferrovie n. 385, il campo sopravvisse all’avvicendarsi di epoche e regimi. Negli anni ’60-’80 fu uno dei più grandi centri di reclusione per prigionieri politici, che continuavano a chiamarlo proprio Dubravlag. Per questi campi passarono molti dissidenti: prigionieri di Temlag e Dubravlag in momenti diversi furono Nina Gagen-Torn, Alla Andreeva, Rostislav Gorelov, Susanna Pečuro, Andrej Sinjavskij, Julij Daniel’, Anatolij Marčenko, Irina Ratušinskaja, Kronid Ljubarskij, Jurij Galanskov, Tat’jana Velikanova e molte altre figure di spicco, scrittori, artisti, studiosi, attivisti … Durante la guerra e nei primi anni successivi (1941-1947) a Po’tma era attivo il campo Temnikovskij n. 58, per prigionieri di guerra tedeschi, ma anche italiani, ungheresi, rumeni e francesi. Molti arrivarono a Pot’ma dal campo Radovskij, tristemente noto e situato nella regione di Tambov. Qualcuno è rimasto per sempre in terra mokši… Tutti gli sconvolgimenti della storia novecentesca russa, e in parte mondiale, in un modo o nell’altro hanno avuto una continuazione in questi sperduti paesi mordovi: qui si concentravano dolori e lutti umani, muti e privi di risposte, e affondavano per sempre nel terreno paludoso.
Il presente passato
All’alba lasciamo la stazione e iniziamo l’esplorazione di Pot’ma. Nell’aspetto attuale del paese, è difficile dire che cosa sia rimasto dal passato e che cosa no. A prima vista non è rimasto nulla del sistema dei gulag. Rimane solo la prigionia vera e propria e un atteggiamento tipico del carcerato: cupa indifferenza e sospetto per ciò che viene dall’esterno. Il sistema qui non è morto, anzi: si è rinnovato e modernizzato con tempismo perfetto. Una recinzione metallica con spire di filo spinato lucido corre per tutta la via Škol’naja [della scuola, N.d.T], dividendola da file grigie di baracche a due piani in mattoni di silicato. Dall’altra parte della strada c’è l’area dove i prigionieri lavorano, sempre recintata. La strada, stretta fra due recinzioni (ma perché allora si chiama “via della scuola”?), è attraversata da un ponticello pedonale. È impossibile vedere chi ci passa: il ponte è ricoperto da lastre di metallo su ogni lato e trasformato in un tubo cieco. Accanto al cancello di ingresso c’è una sorta di vagone ferroviario che però non si muove, una specie di casupola col tetto piatto e il cartello “Stanza dei visitatori”. Si sarebbe potuto scrivere “Stanza delle visitatrici”. Sono soprattutto le donne – mogli, madri, figlie – a venire in visita alla colonia. Una giovane donna e la sua bambina hanno viaggiato dal Kazakistan per diversi giorni, senza dormire, con lunghe attese fra un tragitto e l’altro. Sono venute per una visita di tre giorni al marito, il padre della bambina. Ma prima devono superare lunghe formalità per le visite e i controlli. Una dipendente della colonia chiede con tono severo se hanno droghe. “No, certo che no”, risponde stanca e intimorita la donna, accettando tacitamente la possibilità di essere sospettata di qualcosa. Un’altra donna, più anziana, è venuta da Saransk per vedere suo figlio, ma salta fuori che il figlio non è sulla lista… “Ma allora dov’è? Avevano detto che era stato mandato qui…”. Dopo un po’ l’addetta torna con la notizia che il figlio è stato trovato, ma non in questa colonia; sta in un’altra poco distante, a 19 chilometri da lì. Come arrivarci? Ah, faccia come le pare. Non ci sono né corriere né treni. Chissà perché queste storie ci sembra di averle già sentite, o forse lette da qualche parte…
Consentono a Jurij solo tre consegne all’anno, la nostra era la prima. Ancora prima del viaggio avevamo controllato e pesato con cura il cibo e gli oggetti per lui, ma sul posto ci sono state comunque difficoltà impreviste. Eravamo al corrente di alcune restrizioni (per esempio che tutti i vestiti e le scarpe possono essere solo neri e senza disegni o scritte), ma altre erano una novità. Per ricevere una tuta e delle scarpe da ginnastica, un carcerato ha dovuto scrivere una dichiarazione speciale in cui affermava di non averle. Le addette all’accettazione avevano giudicato un asciugamano troppo grande, ma non hanno trovato limitazioni ufficiali sulla taglia e lo hanno dichiarato ammissibile. Non volevano permettere la consegna del paté a causa della parola “paté” scritta sulla scatoletta. C’era infatti anche scritto che è un prodotto deperibile in breve tempo. Quello portato da noi era in scatolette e mancavano due anni alla scadenza. Ma la scritta dice… Per fortuna, dopo molteplici spiegazioni e dubbi, anche il paté è stato ammesso. Abbiamo aspettato quasi sei ore il nostro incontro, che è poi durato circa due ore; nell’attesa abbiamo compilato parecchi formulari, aspettato la pausa pranzo dei dipendenti e il ritorno dei detenuti dal lavoro. Anche in questo siamo state fortunate. Non tutti riescono a ottenere un incontro proprio il giorno dell’arrivo.
La sala colloqui è in realtà composta da tre locali. Tutti e tre sono stretti, come scomparti di un astuccio, con divisori trasparenti. In due scomparti ci sono panche di legno per tutta la lunghezza. Nello scomparto centrale, i detenuti che ricevono visite devono sedersi in fila; i loro parenti e amici devono mettersi di fronte a loro nella stanza accanto. Le voci, anche se attutite, si trasmettono attraverso la plastica trasparente. Nella stanza dei detenuti hanno messo una barriera davanti alla panchina, a mezzo metro di distanza dal divisorio. Non ci si può avvicinare. Di solito ci sono due o tre colloqui contemporaneamente e per comunicare con l’interlocutore bisogna gridare più dei vicini. Quelli che siedono nel terzo scomparto – e cioè il personale del carcere – osservano e ascoltano attentamente quello che si grida in entrambi gli altri scomparti. Si trovano nella stessa sala stretta, alle spalle dei detenuti, da cui sono separati dalla plastica trasparente. La loro stanzina assomiglia un po’ alla buca del suggeritore o a una cabina da interprete, il loro ruolo però è esattamente l’opposto… Anche in questo caso siamo state fortunate: non c’erano altri colloqui durante il nostro incontro e hanno permesso a Jurij di avvicinarsi al divisorio, per i suoi problemi di udito, certificati da una diagnosi. In questa stanza “a sandwich” siamo riusciti a parlare per circa due ore.
Le condizioni per il lavoro accademico qui, per usare un eufemismo, non sono ottimali. Jurij Dmitriev ha trascorso quasi un terzo degli ultimi tre mesi in isolamento. Subito dopo la nostra visita è stato mandato lì per altri 10 giorni. I motivi sono formalità banali: non ha salutato, non ha messo le mani dietro la schiena e non aveva il cartellino con il nome sui vestiti. In cella di isolamento fa più freddo che nelle baracche e parecchie cose sono vietate. Si può considerarla un’opportunità per svolgere ricerche? Non lo so. Certo è che la potenziale utilità di queste esperienze è esaurita da tempo. Ma non si può sfuggire a questa realtà. Jurij ci racconta che nel prossimo libro vuole esaminare il Temlag e il Dubravlag, campi per prigionieri di guerra, da tre punti di vista: quello dei prigionieri, del sistema concentrazionario e della gente del posto. Le sue fonti – le memorie dei prigionieri di questi campi – gli arrivano per lo più per posta. Non sa se riuscirà a occuparsene nel prossimo futuro. Ora come ora, Jurij riflette per lo più su come scrivere il capitolo sui prigionieri di guerra. Non ha neanche deciso il titolo del capitolo. Dove sono le persone sopravvissute al campo di Pot’ma e ritornate nel loro paese nel 1947? Qualcuno di loro è ancora in vita? Qualcuno di loro ha scritto delle memorie su quel periodo? Come leggerle, se si riuscisse a trovarle? Jurij non sa se riuscirà a scrivere questo capitolo. Ma è chiaro che si tratta di una delle pagine più importanti, anche se quasi del tutto inesplorate, dei campi mordoviani. Quando Jurij racconta, alternativamente, della sua vita qui e della sua ricerca, che per ora non riesce a concretizzare, il suo obiettivo principale risulta evidente: comprendere il campo significa superarlo, vincerlo dall’interno. Ecco perché per lui ora è più importante analizzare il fenomeno in cui si trova immerso e individuarne lo sviluppo storico, piuttosto che scrivere un diario delle sventure che gli capitano. Scherza molto e parla dei suoi problemi ridendo, come se non fossero una cosa seria. Guardandolo ci rendiamo conto di quanto sia importante non fissarsi sulle disgrazie ma, analizzando e confrontandole, mantenere lo slancio per raggiungere il passato attraverso il presente, e viceversa.
Il memoriale
Le ore di luce a novembre sono poche e siamo riuscite a visitare solo le vie centrali del paese. Inutile dire che non abbiamo visto neanche un cartello commemorativo che invitasse in qualche modo a ricordare la sorte delle persone che hanno sofferto e che sono morte nei campi dei dintorni. Tuttavia, parlando con la gente abbiamo scoperto per caso che c’era un memoriale e siamo andate a vederlo. Si tratta di due targhe commemorative collocate in un luogo piuttosto isolato vicino al paese di Moločnica. Non è possibile capitarci per caso, noi abbiamo dovuto cercarle a lungo nella foresta buia e innevata, e addirittura scavare sotto la neve. Le avevano collocate sopra la tomba comune dei prigionieri di guerra del campo Temnikov n. 58. Secondo gli abitanti del luogo, il memoriale è stato fatto da una delegazione venuta qui a metà degli anni ’90 per indagare sulla sorte dei loro compatrioti. Nella loro prima visita trovarono un luogo di sepoltura e l’anno successivo tornarono per mettere le targhe. Ce ne sono due, una per gli italiani e l’altra per gli ungheresi, entrambe con iscrizioni in russo e nella rispettiva lingua: “Agli italiani morti in Russia”; “Qui riposano i prigionieri di guerra ungheresi, vittime della Seconda guerra mondiale”. Non c’era modo di saperne di più, né nessuno a cui chiedere, se avessimo voluto sapere quante persone giacciono qui, perché proprio qui, come sono morte, chi ha eretto il monumento e come. Mentre ci trovavamo davanti a queste lastre al buio, al freddo e nella solitudine, avevamo la sensazione quasi fisica della morsa dell’oblio e del tentativo disperato della memoria di resistere. Quel tentativo era lì. Se ne poteva trovare una traccia e noi l’avevamo trovata.
È sorprendente che in questo luogo, dove il passato è così strettamente intrecciato al presente che sembra non lasciare alcun margine alla memoria, l’unico memoriale che abbiamo trovato sia un ricordo della guerra. Ed è proprio un memoriale che rivela la guerra nel suo aspetto più semplice e terribile, profondamente nascosto nella foresta sotto la neve. Era impossibile non pensare alla guerra in corso, era come se avessimo dissotterrato un ammonimento arrivato troppo tardi, sulla morte anonima e straziante in una terra straniera. Il memoriale non riportava nemmeno i nomi, ma si limitava a ricordare che c’erano state delle persone e che erano morte.
Jurij sottolinea spesso quanto sia importante che la memoria assuma una sostanza materiale. Deve esserci un luogo, un segno che sia associato a quel ricordo e registri che è davvero avvenuta quella catastrofe. Bisogna tracciare nella memoria un solco che opponga una barriera al passo successivo, prima che venga commesso l’irreparabile. A Sandarmoch Jurij ha letteralmente reso materiale il suo pensiero, ponendo all’ingresso del complesso commemorativo un’enorme pietra con la scritta: “Esseri umani, non uccidetevi l’un l’altro”. Ma un appello astratto non è abbastanza. La memoria si risveglia quando tocca i “nostri”, cioè la comunità umana nella quale ci si riconosce e ci si afferma nel mondo in generale: la famiglia, i concittadini, i compagni di scuola, i colleghi, i correligionari. O ancora, i commilitoni italiani e rumeni dei prigionieri di guerra caduti, o il proprio popolo. Ecco perché nei libri sulla storia della Carelia redatti da Dmitriev le informazioni biografiche sulle vittime non sono raggruppate in ordine alfabetico, ma per località. Dopo aver individuato negli elenchi il proprio antenato, si possono trovare i nomi e la sorte dei suoi concittadini e vicini, amici e conoscenti. È un filo conduttore che forse porterà alla nascita di una comunità del ricordo e ne incoraggerà la creazione. “È la memoria che ci rende esseri umani e che rende le nazioni popoli, non popolazioni”, diceva sempre Dmitriev. A Sandarmoch hanno fucilato gente di oltre 50 nazionalità. Dmitriev ha fatto tutto il possibile perché ogni comunità in Carelia potesse commemorare i propri membri e trarre da questa memoria un insegnamento importante per la propria vita odierna. La memoria ucraina è particolarmente forte a Sandarmoch: è qui che è stato giustiziato il fior fiore della cultura ucraina degli anni ’20: poeti, scrittori, artisti, attori e registi di teatro, tutto il cosiddetto rinascimento ucraino. Ogni anno una grande delegazione ucraina veniva a Sandarmoch. In tutto, sul territorio del complesso sono stati eretti monumenti a 25 comunità di varie fedi e nazioni. La memoria della tragedia nazionale è un potente strumento per comprendere la propria identità, l’appartenenza a una nazione che è consapevole di sé stessa. Fornisce un enorme potere per resistere alle influenze esterne. Oggi più che mai è chiara la logica per cui le attività di Jurij a sostegno della memoria sono in contrasto con le posizioni ufficiali. La ruota della violenza ha fatto un giro completo, facendo a pezzi tutte le barriere della memoria, tutti i tabù umani. Non è facile per uno storico affrontare tutto questo, e non solo quando gli rovinano la vita. In quel caso, questa missione rimane forse l’unico modo per rimanere sé stessi e opporsi a ciò che avviene oggi.