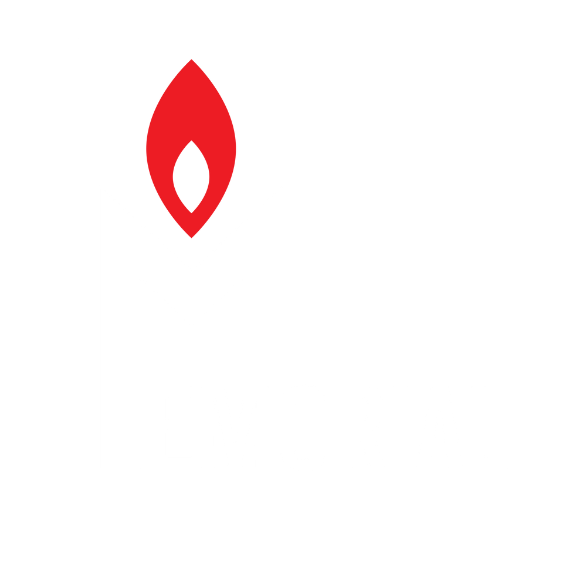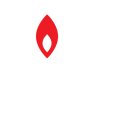Il lavoro femminile nei campi
Le donne, nei campi di lavoro staliniani, svolgevano le stesse mansioni degli uomini, nelle miniere, nel disboscamento, nelle costruzioni… Ma per le donne, che il campo privava della famiglia e della giovinezza, tali mansioni non erano soltanto gravose. Il lavoro comportava umiliazioni e violenza.
——–
Elena Markova è nata nel 1923 a Kiev. I genitori sono stati giustiziati; il padre mediante fucilazione nel 1937. Tra il 1941 e il 1943 ha vissuto nella zona di occupazione nell’oblast’ di Doneck. Dopo la liberazione dell’oblast’ da parte dell’esercito sovietico è stata arrestata da organi dell’NKVD e condannata a 15 anni di lavori forzati. È stata rinchiusa a Vorkuta per 10 anni e riabilitata. È dottore in Scienze Tecniche. Vive a Mosca.
La questione “uomo-donna” per noi era molto penosa. Le ragazze giovani cedevano subito a certe condizioni quando, ecco, i superiori, uomini, avanzavano determinate pretese. Se rifiutavi ti facevano scendere in miniera. E io scendevo molto velocemente, in miniera.
E lì, sottoterra, ho svolto un lavoro per me nuovo, sui vagoncini. Allora non c’erano i cavalli sottoterra, negli anni di cui stiamo parlando. Sono comparsi dopo e i forzati, insieme ai cavalli, spingevano i vagoncini con il carbone attraverso la galleria. Io ero tra questi.
Oppure si costruiva la ferrovia. Anche questo, tra l’altro, era una lavoro orribile.
Sembrava già una buona cosa non lavorare in miniera. Com’era? Costruivamo una ferrovia che si allontanava sempre più dalla nostra zona. Quindi dovevamo camminare, camminare e camminare fino al luogo di lavoro. Alla fine facevamo dieci chilometri per arrivarci e lavoravamo per dieci ore all’aria aperta per costruire questa ferrovia. Poi, dieci chilometri per tornare. Non si trattava della miniera ma in superficie, per la ferrovia. Ma ci stancavamo così tanto, me lo ricordo ancora benissimo come se fosse adesso. Dieci chilometri all’andata e dieci al ritorno, con abiti pesanti, portandosi dietro i badili. Siamo caduti esanimi sulle cuccette senza neanche svestirci. Esanimi. I primi giorni non andavamo nemmeno a cena o a pranzo. Ci davano pranzo e cena insieme. Non avevamo la forza di andare alla mensa.
Ioanna Murejkene (Ulinauskajte) è nata nel 1928 a Kaunas. Nel 1944, dopo il ritorno dell’esercito sovietico, ha appoggiato la resistenza antisovietica. È stata arrestata e condannata a 10 anni di campo di lavoro correzionale, scontati a Komi, Tajšet e Noril’sk fino al 1956. Ha partecipato attivamente alla rivolta del campo di Noril’sk. È una pediatra e vive a Vilnius.
In generale lavoravamo in condizioni molto, molto dure. Ci portavano a scavare la torba. D’inverno bisognava scavare nella neve, ma la torba non gela, non gela. All’inizio trovi uno strato ghiacciato, poi trovi la torba tiepida. Non gela. A che scopo si scavava non si sa. Probabilmente ce la facevano scavare solo per farci lavorare. Si scavava questa torba bagnata con gli stivali, bagnati anch’essi, fradici. Stavamo tutto il giorno in quel pantano. Poi si tornava a casa, gli stivali gelavano. Non è facile raccontare. Arrivi е non c’è un posto in cui asciugarsi, di giorno bisogna far asciugare un po’ i vestiti e tutto il resto vicino alla stufa e alle botti.
Noi lavoravamo là, abbattevamo gli alberi del bosco, li tagliavamo. La quota di produzione era molto alta. Bisognava abbattere sei pini alti con la sega manuale. Non meccanica, manuale. Gi-ru-gi-ru.. Si lavorava così, sa, poi si abbattevano. Fatto ciò, bisognava staccare i rami, in modo da poter tagliare l’albero in tre pezzi da sei metri e mezzo, tre pezzi. Sei pini così, era questa la norma. Un lavoro molto duro.
Vera Jul’evna Chudjakova (Gekker) è nata a Potsdam nel 1922. In quello stesso anno, la famiglia si è trasferita nella Russia sovietica. Nel 1938 il padre è stato fucilato e la madre arrestata. Le sorelle Marsella, Alisa e Vera, studentesse al conservatorio, sono state arrestate nel settembre del ’42 e condannate a 5 anni. Vera ha scontato la pena nei campi di Kirghizistan, Uzbekistan, Siberia e Kazakistan. È un’insegnate di musica. Vive nell’oblast’ di Mosca.
Certo, c’erano le norme. Ma il lavoro che facevo io non poteva avere alcuna relazione con le norme perché non si tratta di norme, in genere era così. cosa può fare, mettiamo, una donna malata o un’anziana o persone così? Noi non avevamo norme da rispettare. Semplicemente ognuno scavava come poteva. Si faceva molto poco, molto poco.
Anna Matljuk (Peca) è nata nel 1927 nel villaggio di Tiškovcy, regione di Gorodenskij, oblast’ Stanislavskaja. Nel 1944 è stata arrestata con l’accusa di partecipazione a un’organizzazione ribelle ucraina e condannata a 10 anni di ITL. Ha scontato la pena partecipando alla costruzione del cantiere n. 501 e dopo la chiusura è stata trasferita nel Osoblag (regione di Irkutsk) per svolgere lavori edili generici. Riabilitata, ha lavorato come bambinaia negli asili nido. Vive nella città di Pečora, repubblica di Komi.
Ci hanno portati fino al cantiere 501.
Là c’erano 50-60 gradi sotto zero. Faceva un freddo terribile. E noi camminavamo. Ogni giorno c’era un controllo, per verificare che ci fossimo tutti, che eravamo arrivati vivi. Si vedeva solo la parte in basso, le facce no. Un gelo talmente forte e una tale brina.
Immagini: le donne portavano le rotaie, spianavamo la strada. Per fare arrivare la ferrovia. La strada era tracciata, un po’. Sono arrivati i mezzi girevoli con sabbia e ghiaia e noi, per due giorni, abbiamo continuato a scaricarli nello stesso luogo. Andava a finire tutto da qualche parte, ecco, come un fiume, un ruscelletto. E noi trasportavamo le rotaie. Ricordo circa 19 ragazze, hanno preso 19 donne. In verità c’era un uomo, il capocantiere, no il caposquadra. Era il caposquadra. Aveva una certa asta. Misurava tutto. Аbbiamo posizionato le traversine. Tutte. Ecco, è così che ho scoperto quanto siano leggere le rotaie.
Elena-Lidija Posnik (Koz’mina) è nata nel 1924. Nel 1945 è stata deportata e condannata a 15 anni di lavori forzati. Ha scontato la pena nell’oblast’ di Archangel’sk, regione di Krasnojarsk, e nella Kolyma. Riabilitata, ha lavorato come insegnante di tedesco. Vive nell’oblast’ di Mosca.
Poi, lavori generici. Di cosa si trattava? La chiamavano cassiterite. Adesso, invece, credo la chiamino uranite. È una roccia nera, nerissima. Ecco, come il granito, ha presente? Ha delle macchie, tutte nere. Ed è tutto radioattivo. Emana radiazioni. Una sacca come quella erano cinquanta chili. Poi mi hanno affidato questo compito. Erano lavori generici. Dove? Ti davano dei contenitori così, di queste dimensioni. Quindi, da sotto, li facevano saltare. Là si metteva la sabbia. Si prendeva in spalla, si apriva e si travasava e nel travasare volava in giro. Sul secondo livello. I livelli erano cinque. Dunque si raccoglieva ancora più in basso. Poi, ancora più giù, c’erano quelli subacquei. Tutto questo veniva poi portato al processo di arricchimento.
Per farla breve, finché si va dove si riversa, tante si staccano, tante si rompono. Le rocce. Dei massi così. E non avevo paura. Se muoio, pazienza. Pensavo solo: come farà mia mamma? Mi dispiaceva solo per lei.
Susanna Pečuro è nata a Mosca nel 1933. Arrestata nel 1951 all’età di 17 anni, è stata condannata a 25 anni di ITL. Ha scontato la pena nei campi di Inta, Abez’, e nella prigione della centrale di Vladimir fino al 1956. Riabilitata, è storica e archivista. Vive a Mosca.
Era un lavoro di sterro. Dovevamo rompere il ghiaccio perenne con il piccone, caricare sulle carriole e trasportare per 300 metri, scaricare e compattare il tutto. quando si ghiacciava, dovevamo fare tutto là e riportarlo indietro. E come diceva il nostro caposquadra: “Io non ho bisogno del vostro lavoro, mi servono i vostri tormenti”.
Vera Jul’evna Chudjakova
50 chilometri da Frunze, si chiamava Belovodsk. Là stavano costruendo uno zuccherificio. C’era un terreno con la barbabietola da zucchero e stavano costruendo uno zuccherificio.
Noi scavavamo e portavamo via la terra con le carriole. Si usava la terra per costruire degli argini, qualcosa di strano. Comunque, raccoglievamo la terra da qualche parte, poi tornavamo indietro. Allora, c’erano queste tavole, la pavimentazione e, ecco, per questo bisognava usare le carriole, riempire e trasportare. Mi piaceva molto perché stavo all’aria aperta e io ero scalzo. E mi piaceva quel genere di lavoro. Nel periodo che ho trascorso in carcere non ho fatto nulla. Certo, mi piaceva. Ma le condizioni erano davvero spaventose.
Ioanna Murejkene
Erano lavori di sterro. Dovevamo scavare con i picconi tutto il sistema di canalizzazioni sotto Noril’sk, tutte le strutture. Tutto scavato dalle mani delle donne, con i picconi, pezzo per pezzo. Spesso lavoravamo di notte, estate e inverno. Quando eravamo ancora nei fossi lavoravamo tutti insieme, potevamo vederci. A Noril’sk le case erano costruite su pilastri di calcestruzzo e bisognava piantarli a 9 metri di profondità. Quindi bisognava scavarli nel ghiaccio, nel ghiaccio perenne, questi nove metri di profondità. Ci portavano, ci sistemavano e ognuno si distanziava. Fintanto che stavi sopra vedevi gli altri e potevi parlarci e tutto il resto. Quando si scavava sotto, già a sei metri, rimanevi da solo. E quando capitava, sa, era terribile.
I.O. Come in una tomba.
I.M. Come in una tomba. A volte pensavi che, probabilmente, ci saresti rimasto. Si portava via con un secchio quest’argilla, questa terra, poi calavano il secchio e tu, di nuovo scavavi, calavi e portavi via. Lavoravamo così finché non raggiungevamo i nove metri. Di notte, tutta la notte, lavoravamo soprattutto di notte. Quando svolgevamo questo lavoro mangiavamo poco. Avevamo fame.
Elena-Lidija Posnik
Ma ad aprile ci hanno costretto ad andare a lavorare. Dove? Ad abbattere gli alberi del bosco. Al disboscamento. Che bosco c’era, lì? Beh, probabilmente l’abete più grande arrivava al tetto. Ma la neve alla vita. Dunque, ci facevano fare circa cinque chilometri nell’oscurità. Ci portavano là. Tutti quanti, inclusa me. Non c’era nessun altro. Ci portavano là e bisognava segare due metri cubi, caricarli sulla slitta e portarli giù. Ma bisognava segarli di sopra. Nessuno prendeva me. Innanzi tutto, non sapevo scegliere la sega, inoltre non sapevo usarla. Si è avvicinata un’ucraina e ha detto: “Sono credente e sento di dover aiutare le persone. Dai, segherò io con te”. E ho lavorato con questa ragazza, non più grande di me, ecco, le slitte, di questa lunghezza. Cioè, tagli semplicemente due metri in lunghezza. Per passare da un albero all’altro ti metti carponi, appogiandoti alla sega perché altrimenti sprofondi.
Vera Jul’ievna Chudjakova
Siamo andati a lavorare nei campi. Abbiamo camminato tutto il giorno e, naturalmente, è stato terribile perché non tutti erano in grado di camminare come me. Anche adesso cammino bene. Da giovane, anche se ero debole, camminavo comunque. Altri, invece, non riuscivano proprio e, naturalmente, era terribile quando cadevano.
Là c’erano circa, non so, una ventina di persone, comunque non molte. E si camminava in fila per quattro. Quando qualcuno cadeva e non riusciva più a camminare la guardia andava fuori di testa e minacciava di fucilarci e quant’altro. Terribile!
Ioanna Murejkene
Si faceva ogni genere di lavoro. Ci hanno portati a Sivomaskinskij a scaricare i vagoni. Era un lavoro duro. Se arrivavano le traversine dovevamo scaricare le traversine e se c’era il carbone, una pessima cosa, il carbone. Arrivava un vagone di carbone e allora bisognava scaricarlo vicino alla ferrovia con i badili. Era terribile, diventavamo neri, c’era polvere. Era bruttissimo quando portavano il cemento. Nei sacchi di cemento, questi/, questo cemento lacerava i sacchi, faceva polvere, ma bisognava comunque scaricare il cemento dai vagoni. Noi respiravamo quel cemento, gli occhi si arrossavano, i capelli si riempivano di cemento, era davvero molto dura. Appena me lo mettevano in spalla cadevo sotto quel sacco. Tutti ridevano: “Forza, forza! ti ci abituerai”. Effettivamente, pian piano, all’inizio cadevo poi mi piegavo e camminavo. Mi raddrizzavo e andavo con il sacco, così sa [ride]…
Era molto duro lavorare nella fabbrica di mattoni. C’era una fabbrica di mattoni, che produceva mattoni. Non li prendevano, li facevano loro direttamente; tutta Noril’sk è stata costruita con quei mattoni. Molti uomini lavoravano nella fabbrica di mattoni. E noi donne siamo state mandate a lavorare ai forni. Ohi, se esiste l’inferno noi ci siamo state. Io dicevo sempre: “Probabilmente abbiamo già pagato per i nostri peccati, là”. Erano quei forni che si accendevano dal basso.
C’era un caldo! Un caldo! Doveva esserci un gran caldo affinché l’argilla si fondesse. Un caldo che non si resisteva, ci sfiancava. Non riuscivamo più a sollevare l’argilla con i badili. Lavoravamo per dodici ore. La nostra giornata lavorativa era di dodici ore. E per dodici ore facevamo questo lavoro., Eravamo talmente sudati e stanchi che, quando portavano l’argilla congelata, ci sdraiavamo sopra di essa così che, per un po’/.
La sete era impossibile. Volevamo bere! Sembrava che ancora un minuto, due, poi saresti crollato. Comunque, appena finito di lavorare tornavamo a casa. Arrivavi lì e sembrava che appena ti fossi addormentato dovessi di nuovo alzarti, poi ancora e ancora.
Susanna Pečuro
Fatto questo lavoro ti riportavano a casa. Quel giorno mi sono data il piccone sulla gamba. Si lavorava per 12 ore. Non ci si poteva sedere, da nessuna parte. Non ci si poteva allontanare, scusi l’espressione, per le proprie necessità. Indossavamo pantaloni di cotone. Niente cibo a parte il pane congelato che ti portavi in seno. Era un bene che fosse congelato, perché così almeno si poteva succhiare. E lo mangiavi subito.
Elena Markova
Dunque, un campo di lavoro di madri e ragazzini. Nell’ITL, già prima del nostro arrivo, c’erano campi ufficialmente per madri e ragazzini, in cui si trovavano i detenuti. Già prima dei lavoratori forzati. C’erano storie diverse. Quando sono finiti là i trozkisti con un bambino, e tra i miei conoscenti ce n’erano, o finivano in prigione mentre erano incinte, oppure in un campo di lavoro; venivano mandati nei campi per madri e bambini a nord di Komi, che esistevano ufficialmente già dagli anni Trenta. Rimanevano lì finché non glieli portavano via per mandarli in un orfanotrofio.
Ma il figlio di una forzata non veniva mandato in un ITL, dove c’era un campo per madri e bambini. Nel settore maschile dei forzati era stata allestita una baracca separata dove raggruppare tutti questi bambini. All’inizio erano dieci, poi sedici, poi ancora cento e più. Conosco bene il problema perché mi hanno mandata lì a fare l’educatrice.
All’inizio come infermiera, poi ci si è resi conto che i bambini in orfanotrofio non parlavano russo. Perché avevamo un contingente che veniva dalla zona occupata. Chi erano? La parte del leone veniva dall’Ucraina. Nell’Ucraina orientale non si parlava russo. Poi dal Baltico. Erano tedeschi, polacchi. Tutto dalla parte occupata. Tutte le mamme hanno iniziato a parlare con i figli nella propria lingua madre. I figli sono cresciuti, l hanno messi in un orfanotrofio, ma non parlavano russo.
Così, hanno deciso che se c’era una ragazza, ai lavori forzati, che non desiderava altro che studiare, allora poteva insegnare qualcosa ai bambini. Ed effettivamente, ho iniziato a insegnare a quei bambini. Questa impresa nel campo di lavoro è molto cara al mio cuore.
Fino ai tre, quattro anni d’età, i bambini stavano insieme alle madri nel campo ed erano miei allievi. Abbiamo subito fatto amicizia e loro, tutte le mamme, mi stimavano come educatrice. Perché vedevano che io li facevo disegnare, giocavano con le illustrazioni, facevano degli spettacoli, dei concerti.
In generale, là abbiamo fatto un lavoro enorme per creare delle condizioni che, per loro, non fossero quelle dei forzati.
Testi:
Alena Kozlova, Irina Ostrovskaja (Memorial – Mosca)
Operatori:
Viktor Griberman (Riga)
Andrej Kostjanov (Mosca)
Andrej Kupavskij (Mosca)
Ivan Kupcov (Mosca)
Montaggio:
Sebastian Priess (Memorial – Berlino)
Jorg Sander (Sander Websites – Berlino)
Traduzione: Zeno Gambini